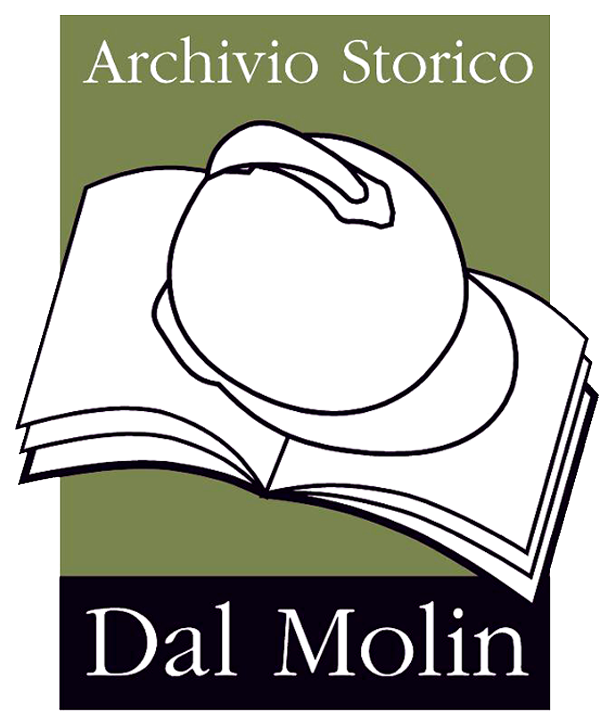CAPORETTO O VITTORIO VENETO?
di MARCO VITALE (*)
Confesso che, sino verso la fine degli anni ’70 del Novecento non conoscevo la esemplare figura del Capitano Emilio Lussu (se non come importante parlamentare e leader del partito sardo d’azione) né la Brigata Sassari. Me li fece conoscere Ermanno Olmi parlandomene nella sua bella casa di Asiago al limite dell’Altopiano dei Sette Comuni, uno dei territori dove si sono combattuti, in furiose battaglie, l’esercito austro-ungarico e quello italiano, ed uno dei luoghi dove Emilio Lussu e la Brigata Sassari hanno costruito, con il loro coraggio e la loro dignità, la loro meritata gloria. Ermanno Olmi era molto affascinato da entrambi, e da tempo coltivava l’obiettivo di raccontarli in un film. Il sogno di Ermanno non si realizzò per vari motivi, ma il pensiero di quel Capitano e di quella eroica Brigata in quella Grande Guerra e del suo significato non lo abbandonò mai. Ancora nei primi anni ’80 me ne parlava. Il film che voleva fare sarebbe stato contro la guerra con le sue miserie, le sue cattiverie, le sue infamità, la sua ottusità, ma, al contempo, Ermanno voleva raccontarci come, tra tante miserie e sofferenze, potevano emergere dei personaggi come il Capitano Lussu e i combattenti della gloriosa Brigata Sassari con il loro grande coraggio e con la loro grande dignità. Avrebbe voluto raccontarci che gli uomini restano uomini anche in trincea. Avrebbe voluto capire e farci capire da dove proveniva tutto quel coraggio, quella dignità dei contadini, pastori, muratori sardi che si battevano senza risparmio. Parte del suo sogno Ermanno lo ha concretizzato nel suo straordinario: “Torneranno i prati”, girato sull’Altopiano dei Sette Comuni, come bene illustra Stefano Aluisini nel libro “Il Capitano Emilio Lussu: il Carso, l'Altopiano e il Piave che non ha mai raccontato” (Itinera Progetti Editore, 2024, pagg. 453):
“Per non parlare, infine, dell’indimenticabile affresco fatto in “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi (2014) il quale, essendo di gran lunga e davvero un film “contro” la guerra, pur senza alcun riferimento diretto al libro di Lussu ne amplifica in realtà all’estremo, secondo i canoni del grande regista, tanto i sentimenti quanto la percezione dell’ambiente maestoso dell’Altopiano. Qui la violenza assurda della guerra, cieca ma a sua volta invisibile, si esprime con un bombardamento in una trincea quasi casualmente a travolgere un microcosmo umano sprofondato in una trincea isolata e buia, protetta solo da tronchi e sacchetti a terra, senza far mai vedere un soldato austriaco. Sotto le granate restano soltanto creature indifese, con i loro grandi occhi bianchi e sconsolati spalancati sui volti anneriti dalla sporcizia, le barbe lunghe e i capelli cisposi, i corpi infreddoliti avvolti dalle uniformi sporche e stracciate, tutti riuniti attorno a un mozzicone di candela pur di guardare, per l’ultima volta, la fotografia stropicciata della famiglia. Sono questi i veri uomini “contro”, quelli con lo sguardo perso nella gavetta di neve sciolta vicino alla stufa per poter bere, gettati su un pagliericcio pulcioso in mezzo al fango che orinano prima di uscire dalla trincea a farsi uccidere. Anche nel film di Olmi compaiono ordini surreali dati da ufficiali isterici, magari dietro la promessa di una licenza o di qualche soldo, così come i sacrifici inutili di tanti soldati-contadini commentati a mezza voce nei vari idiomi della penisola. E quando gli uomini non hanno più nemmeno la forza di guidare i muli nella neve alta, sono questi ultimi a risalire da soli come automi il sentiero verso la trincea, portando stancamente a destinazione il loro carico. Gli illumina il cammino la luna piena, con i suoi raggi scintillanti riflessi dalla dorsale innevata del Portule, mentre sul fruscio degli zoccoli sprofondati nella neve si leva dalla trincea, soffusa e malinconia, una canzone. È il ricordo della terra natia, lontana e impossibile, magari quello di un amore perduto o lasciato in angosciosa attesa, una speranza di sopravvivenza o forse l’ultima preghiera prima della fine, quel sentimento che finisce nel perdersi tra i larici verso fondovalle da dove, di tanto in tanto, lampeggia inesorabile la violenza della guerra per ricordare agli uomini il loro destino. Perché “dietro quella memoria c’era qualcosa di straordinariamente carico di sentimenti… E da lì ho cominciato a pensare: può esserci una guerra che uccide gli uomini ma non i sentimenti”? Ecco, proprio questo “galleggiare di sentimenti” del Maestro Olmi è in estrema sintesi molto del vissuto di Emilio Lussu nella Grande Guerra, quello raccontato nel suo “Un anno sull’Altipiano”, ovvero tutto ciò che in fondo mancò nel film di Rosi”.
Fanti della Brigata “Sassari” in trincea sull’Altopiano di Asiago
Ah, come sarebbe piaciuto a Olmi questo libro: quanti spunti, quante conferme, quanti personaggi, quante battaglie avrebbe, in esso, trovato o ritrovato. E sono certo che avrebbe condiviso il mio giudizio, che si tratta di un libro bellissimo. Ma devo rendere conto di questo giudizio per me non usuale. Innanzi tutto, è bellissimo perché racconta di un personaggio (Il Capitano) e di una brigata (la Brigata Sassari) che sono “bellissimi”. E, in secondo luogo, è scritto benissimo. Si usa dire dei libri di storia o scientifici che riescono ad avvincere (io l’ho preso in mano tre giorni prima di Natale e non sono riuscito a staccarmene sino alla fine, proprio nel giorno di Natale): si legge come un romanzo. Ma romanzo non è. È storia, è vita concreta di persone concrete, con nome e cognome, persone che hanno vissuto e sofferto quella che uno storico inglese ha definito il più atroce conflitto di ogni tempo (N. Ferguson, The Pity of War, 1998 trad. italiana Il grido dei morti. La Prima guerra mondiale, il più atroce conflitto di ogni tempo Mondadori, Milano, 2017). E non è storia romanzata o di grandi masse anonime. È storia minuziosamente e scrupolosamente documentata sulla base dei documenti ufficiali, delle memorie dei protagonisti, del lavoro prezioso degli storici che hanno in gran parte portato alla luce la realtà della grande e dolorosa guerra, della letteratura e in primo luogo il libro che lo stesso Lussu dedicò a una fase importante della sua vita di guerra (Un anno sull’Altipiano, Einaudi 2003), un libro molto amato da Ermanno Olmi. È un libro bellissimo anche perché è il frutto maturo di un grande impegno, tre anni di lavoro, di ricerca appassionata ma scientificamente rigorosa, che rappresenta il culmine di un lavoro di ricerca e documentazione condotto da decenni che Aluisini e Dal Molin hanno dedicato alla Grande Guerra, nelle biblioteche ma anche negli archivi di uffici pubblici e militari, battendo il territorio e dando vita ad archivi foto-bibliografici privati di grande pregio ed importanza. È storia dal basso, alla Braudel, scritta dalle persone e dalle cose e vicende reali e quotidiane. E questo la rende più vera, senza mai cedere alla retorica e al “grandiosismo” (Luigi Zoja) delle narrazioni e dei documenti ufficiali:
“L’Istituto Italiano di Cultura, che ha sede a Parigi di fronte all’Ambasciata, è forse il più importante, certamente il più bello tra questi enti italiani sparsi per il mondo. Passato l’arco d’ingresso, si incontra una targa con il Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918 firmato da Armando Diaz. È un “falso resoconto (che) non venne mai messo in discussione dai militari né dai giornalisti (…). Nel giro di un paio d’anni esso trapassò senza soluzione di continuità nella glorificazione fascista della guerra” (M. Thompson, The White War, Life and Death on the Italian Front 1915-1918 (2008) trad. it. La guerra bianca. Vita e morte sul fronte italiano 1915-1918, Il Saggiatore, Milano 2009, pagg. 385). Falso dal principio, dove afferma che l’Italia iniziò la guerra “inferiore per numero e per mezzi” (era abissalmente superiore) alla fine, in cui pretende di aver sconfitto “uno dei più potenti eserciti del mondo” (quella austriaca era la più debole fra le armate in campo già a inizio guerra; nel novembre 1918 era ridotta a una colonna di sbandati). Una lapide spaccona è già un disturbo in patria; ma a Parigi potrebbe leggerla un visitatore con sottobraccio i testi di storici francesi come Bled, Bérenger, Fejtö, Michel, che la contraddicono completamente. L’Italia fu tenuta lontana dalla verità contenuta non solo nei documenti, ma anche nei romanzi. Addio alle armi, in capolavoro in parte autobiografico di Hemingway sulla guerra, fu vietato in Italia e pubblicato solo nel 1948”. (Luigi Zoja, narrare l’Italia, Bollati Boringhieri 2024, pagg.352).
Secondo Luigi Zoja (op.cit. pagg. 352):
“Ecco le armate in campo nelle principali Battaglie dell’Isonzo, centro del conflitto italo-austriaco. Maggio-giugno 1917, decima battaglia: 32 divisioni italiane contro 16 e mezza imperiali; undicesima, agosto-settembre: 55 e mezza italiane contro 20 e mezza, poi 29 austriache. Anche flotta e aviazione asburgiche erano la metà di quelle avversarie. Fino a questo punto, in undici devastanti attacchi gli italiani non erano sostanzialmente avanzati, malgrado avessero mantenuto una schiacciante superiorità dall’inizio della guerra: nel complesso, erano 10 contro 4 per numero di uomini, con un vantaggio ancora superiore nei mezzi, in particolare nell’artiglieria. La dodicesima è nota come Battaglia di Caporetto”.
Un bombardamento sulle trincee del Carso
Dopo due anni e mezzo di guerra, dolorosissima e feroce, ma quasi statica nelle trincee, in soli quattro giorni Cadorna aveva perso più di metà del Veneto. Cadorna addossò la responsabilità di questo crollo alla vigliaccheria dei fanti italiani (bollettino di guerra 887, 28 ottobre 1917). Ma sono proprio queste storie dal basso, queste storie vere che permettono agli autori di parlare di eroi e di comportamenti eroici ed umanamente commoventi senza mai cadere nella retorica. Leggendo queste vicende vere di un grande personaggio come Emilio Lussu e di una grande squadra come la Brigata Sassari, sembra quasi di rivivere queste vicende insieme a loro; di essere insieme sul Carso, sull’Altopiano, dalla Bainsizza a Caporetto e nella meno conosciuta ma decisiva battaglia dei “Tre Monti” sino al Piave.
Sopra: in trincea sul fronte della Bainsizza, agosto 1917; sotto: alcuni Fanti della 12^ Compagnia del Ten. Alfredo Graziani del III Battaglione del 151° Fanteria nelle trincee dell’Altopiano dei Sette Comuni in attesa dell’assalto.
Come si presenta ancora oggi il campo di battaglia del Col del Rosso - Cascina Melaghetto, con ancora i crateri delle esplosioni delle granate che segnano i prati.
La lapide in memoria della “Sassari” al Municipio di Calcinato (BS)
Sembra quasi di vederli questi giovani sardi organizzarsi e fare le prime esercitazioni tra Lonato e Calcinato (paese del bresciano poco distante da San Martino e Solferino dove si svolse la Seconda Guerra di Indipendenza nel 1859), paese che li accolse con amicizia e ospitalità e che ne conservò a lungo memoria. E sembra di trovare, insieme a loro, conforto nel dolcissimo sorriso di Teresa Nardini l’amatissima “Madrina” della Brigata Sassari, formata da quei soldati che, dopo i primi scontri sul Carso, furono chiamati dai soldati austro-ungarici “Die Roten Teufel”: I Diavoli Rossi.
Teresa Nardini in compagnia di alcuni feriti della Brigata“Sassari” all’Ospedale Militare di Riserva di Bassano del Grappa
Uno dei cimiteri della Brigata “Sassari” in Altopiano
Ma il prezzo fu molto alto. La Brigata Sassari registrò complessivamente 1734 caduti (tra i quali 138 ufficiali) 2085 dispersi (tra i quali 50 ufficiali) e 9104 feriti (tra i quali 359 ufficiali).
La Sardegna fu tra le regioni con il maggior numero di uomini mobilitati. Su circa 800.000 abitanti in Sardegna vennero mobilitati 98.142 uomini, pari al 14%, rispetto a una media nazionale di poco superiore al 10%.
Forse non avevano quindi del tutto torto i reduci sardi della Grande Guerra quando cantavano:
“Non sezis voi sos continentales
ch’azis difesu su trinceramentu,
su chentuchimbantunu reggimentu,
chentuchimbantaduos tottu in pares.
(Non siete voi continentali
che avete difeso le trincee,
ma tutti assieme, quelli del centocinquantuno
e del centocinquantadue)
(Canto dei reduci sardi della Prima guerra mondiale) (1)
Cippo della Brigata “Sassari” sulle pendici di Monte Fior - Castelgomberto - Altopiano dei Sette Comuni
Ma se è vero, come è vero, che sul Carso, sull’Altopiano ai tempi della “Strafexpedition” austro-ungarica, ed a Caporetto, il coraggio, la compattezza e la forza fisica e morale della Brigata Sassari e dei molti dei suoi ufficiali furono esemplari e importantissimi, è altrettanto vero che è su questo fronte che avvenne la vera unione degli italiani, per la prima volta uniti in una grande sofferenza. Luigi Zoja (op. cit. pagg. 351 e 355) ci ricorda che Caporetto è tra i territori ad Ovest dell’Isonzo che gli austriaci avevano, per ragioni tattiche, sgomberato volontariamente, che il nome di Caporetto era Kobarid e non si parlava italiano ma sloveno. Eravamo noi gli invasori, in gran parte per incomprensibili motivazioni, come scrive Zoja (op. cit. pag. 355):
Un’immagine della ritirata di Caporetto (settore Tagliamento).
“La dodicesima (battaglia) è nota come Battaglia di Caporetto. Con la Rivoluzione in Russia e la sua uscita dal conflitto, la Germania aveva potuto mandare qualche rinforzo agli austro-ungarici e la disparità di forze si era ridotta: 41 divisioni contro 33 austro-tedesche. “Caporetto”, in italiano, diventò un concetto a sé, equivalente a disastro. Si sfasciò non solo il fronte ma la disciplina dell’esercito. Questo non rivelò tanto una vigliaccheria del fante italiano, quanto una sua ridotta identificazione coi comandi e un desiderio di ribellarsi; che esistevano anche in altri eserciti ma non in queste proporzioni. La separazione tra ufficiali e soldati era particolarmente forte, quella con gli alti comandi fortissima. Man mano che proveniva più dal sud, la truppa capiva meno i comandi; sia letteralmente per la loro lingua, sia per la mentalità. Diversi aspetti della gerarchia militare continuavano a far pensare a un Sud colonizzato. Cadorna e Badoglio, due persone che segneranno l’Italia nella prima metà del Novecento, erano piemontesi, cioè ancora piuttosto “stranieri” alla maggior parte della truppa. Storici anglosassoni arrivano a definire i comandi “sadici” o “perversi”, anziché autorevoli, o a segnalare che la “cultura piemontese” permeava la monarchia, l’esercito, i ministeri. Gli ufficiali di altre regioni, salvo qualche eccezione, avevano molte più difficoltà nell’essere promossi. Alla fine della guerra si trovavano agli atti 1050 fucilazioni di soldati, ma il numero reale era superiore: molte non erano state registrate. Per fare un paragone, nell’esercito tedesco (secondo i luoghi comuni, il più severo) ne risultano solo 50, anche se la truppa era il doppio di quella italiana e la guerra durò un anno di più”.
È quando ci si interroga sugli obiettivi e conseguenze di questa Grande Guerra che le cose si complicano. Per sua fortuna il bellissimo libro di Aluisini-Dal Molin non deve entrare in queste complicate domande, non deve formulare giudizi o auspici o previsioni, ma semplicemente e scrupolosamente racconta storie di uomini e di persone specifiche e vere. Ma sono proprio queste storie personali, che ci interrogano, ci ripropongono continuamente queste domande difficili.
Emilio Lussu da giovanissimo sottotenente era fervente interventista perché, come tanti, pensava che la guerra avesse un senso etico, fosse formativa, fosse un esame. Ma sul Carso capì rapidamente che la guerra era solo crudeltà e “inutile strage” e diventò nemico della guerra pur continuando a fare, con sprezzo del pericolo e con dignità ed onore, il comandante responsabile. Ermanno Olmi che non ricordava la Prima guerra mondiale ma ricordava bene la seconda era contro la guerra sempre e comunque e parlava della prima guerra con parole che riproduco nella speranza che ci aiutino a riflettere sulla guerra in generale e su quella che tanti folli hanno, passo dopo passo, preparato:
“La grande Guerra sull’Altopiano” (2)
“Di qua il prete che ti benedice e di là il carabiniere che, se non esci dalla trincea, è pronto a spararti”. Sono passati più di quarant’anni da quella volta che Toni Lunardi, un vecchio pastore dell’Altopiano, mentre stavamo sul bordo di un camminamento, mi indicava il punto della trincea da dove i soldati dovevano uscire per andare all’assalto. “O vai a morire là fuori o muori subito qua dentro”, Seicentomila soldati italiani lasciarono la loro giovinezza sui campi di battaglia per ordine dei loro comandanti criminali. Bisognerebbe scriverlo sui monumenti, in fondo all’elenco dei caduti: “Questi sono i nomi di giovani uomini sacrificati all’assurdità delle guerre per ordine dei loro generali”. I loro nomi, scolpiti sulle lapidi, sembrano nomi da poveri. Toni Lunardi stava in silenzio. Si riscosse solo quando da lontano giunse l’abbaiare dei cani che radunavano le vacche per la mungitura. “Andemo per ‘sta parte de qua” mi disse nel suo dialetto limpido, essenziale, da montanaro. Non era un suggerimento e neppure un ordine. È così e basta. Prendemmo per un sentiero appena tracciato sull’erba del pascolo. Toni Lunardi conosceva tutte le vie che portavano dove si vuole andare. E se non ci fossero stati sentieri, lui avrebbe saputo ugualmente come orientarsi. “Mai attraversare “mugare”. I pini mughi sono traditori: credi di mettere i piedi sul sicuro e loro invece cedono e ti fanno sprofondare”. È vero: ci si può rompere una caviglia e non si torna più a casa. Camminava silenzioso e solo ogni tanto mi indicava qualcosa: “vedi quell’erba là, com’è più verde dell’altra? Là sotto ci sono quelli che si sotterravano dopo gli assalti”. Si fermò prima di proseguire: “Quell’erba è cresciuta sulla carne umana”. Era il 1967 quando vidi quel prato coi miei occhi. Cinquant’anni dopo le tracce della grande Guerra non erano ancora scomparse. Quasi altrettanti anni sono trascorsi da quando pronunciò quelle parole. Ma io non le ho più dimenticate. Allora, Toni Lunardi aveva ottantun anni. Gli stessi anni che ho io adesso. Aspettai che fosse lui a muoversi, secondo il tempo dei suoi pensieri. Non rimase a lungo in silenzio. “Dopo tutti questi morti, cos’è cambiato? Finita la guerra, quelli che l’hanno scampata tornano ognuno a casa propria, che tanto non cambia mai niente”. Per il resto della strada non disse altro”.
“Arditi” reggimentali della Brigata “Sassari” in linea sul fronte del Piave intenti a consumare il rancio.
Soldati della “Sassari” a Santa Lucia di Piave nei giorni di Vittorio Veneto ritratti con alcuni cannoncini austro-ungarici di preda bellica
Quando il 1° agosto 1914 iniziò la Grande Guerra, Giuseppe Prezzolini fu subito interventista contro l’Austria- Ungheria, come era Emilio Lussu. Il suo interventismo non fu nazionalista né irredentista ma motivato da una concezione etica della guerra, come una sorta di esame per i popoli “Si tratta di passare il nostro esame. Fummo, finora, una nazione aspirante al grado di grande. Oggi non si tratta neppure di questo ma di ben altro: si tratta di sapere se siamo una nazione”. Quando l’Italia entrò in guerra Prezzolini si arruolò come volontario e il 27 agosto 1815 partì per il fronte. Pochi mesi di guerra furono sufficienti per fargli cambiare totalmente la sua visione della guerra. Subito dopo la fine della guerra il capitano del Regio Esercito Giuseppe Prezzolini scriveva due reportages per “La Voce”. Dopo Caporetto (novembre 1917) e Vittorio Veneto (marzo 1920) (3). Di essi Prezzolini scriveva: “Se volessi esprimermi paradossalmente, direi che Caporetto è stata una vittoria, e Vittorio veneto una sconfitta per l’Italia. Senza paradossi si può dire che Caporetto ci ha fatto bene e Vittorio Veneto del male; che Caporetto ci ha innalzati e Vittorio Veneto ci ha abbassati, perché ci si fa grandi resistendo ad una sventura ed espiando le proprie colpe, e si diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e facendo risorgere i cattivi istinti per il fatto di vincere”. Caporetto come vittoria. La tesi è solo apparentemente paradossale. Nella disfatta di Caporetto il popolo italiano forse per la prima volta si dimostrò unito (e il libro di Aluisini – Dal Molin ce lo conferma) e seppe, unito, guidato da un napoletano, con la più onorata Brigata formata da soldati sardi, con la canzone del Piave, diventata una sorta di inno nazionale, scritta e musicata anch’essa da un napoletano a Bergamo, resistere sul Piave e sul Grappa preparandosi all’inseguimento di Vittorio Veneto dei resti dell’esercito austriaco già in disfacimento.
“Caporetto fu, sotto questo aspetto, una rivelazione straordinaria. Non si dirà mai abbastanza il bene che Caporetto ha fatto all’Italia. Sembrò restituire al paese il buon senso, la misura, l’umiltà, la volontà seria, la concordia, il senso della precisione, la coscienza severa dei propri atti, che tanto avevano scarseggiato nei primi retorici anni di guerra.
L’esercizio di verità cui ci costrinse ebbe ottimi effetti. Ci si può rammaricare che noi dobbiamo imparare sempre a così caro prezzo; ci si deve augurare che nel futuro non sia necessario sempre passare col dito sulla fiamma per sapere che brucia. Ma non resta che prendere atto di questa caratteristica della storia nostra recente: che i periodi più sani della nostra vita sono stati quelli in cui, avendo duramente battuto contro la realtà, ci siamo raddrizzati ed abbiamo imposto a noi stessi di cambiare strada.
Lo storico dell’Italia futura dirà molto bene di Adua e di Caporetto; cioè, dirà molto bene degli italiani, perché, in fondo, non è una qualità da disprezzare quella di sapersi correggere. Caporetto, dunque, ci curò; quello che è accaduto dopo Vittorio Veneto dimostra però che non ci guarì…Ma perché ci deve esser sempre bisogno di un Caporetto per imparare a conoscere la realtà?”.
È questa una domanda che dobbiamo porci anche oggi nel frastuono che ci avvolge e che confonde ogni cosa. Libri come quello di Aluisini e Dal Molin, con il ricordo di persone vere, anticonformiste, piene di umiltà e di pietas, come Emilio Lussu ed i suoi colleghi e soldati sardi ci aiutano a riflettere su questa difficile domanda.
Marco Vitale Brescia, 10 gennaio 2025
Scritto a commento del libro di Stefano Aluisini – Ruggero Dal Molin, Il Capitano Emilio Lussu: il Carso, l'Altopiano e il Piave che non ha mai raccontato (con 350 fotografie). Itinera Progetti Editore, luglio 2024, pagg. 453.
(1) Lorenzo Cadeddu, La storia della Brigata Sassari nella guerra del 1915 (Paolo Gaspari Editore, 2008)
(2) Ermanno Olmi, L’Apocalisse è un lieto fine, Storie della mia vita e del nostro futuro, Rizzoli, 2013, pagg.78
(3) Giuseppe Prezzolini, Dopo Caporetto – Vittorio Veneto, Edizioni di storia e letteratura, giugno 2015 pagg. 154. Per la prima volta apparsi nelle edizioni della “Voce” 1919, 1920.
(*) Economista d’impresa, bresciano di nascita, milanese di residenza, internazionale per cultura e attività. Nato nel 1935, è sposato con Mimma, toscana, e ha due figli, Luca e Nicola. Appassionato alpinista, sciatore e viaggiatore è stato sulle o intorno alle montagne dell’Alaska (McKinley), della Cordillera Real in Bolivia (Ancohuma - Illampu), della Cina (Minya Konga, nelle Alpi del Sichuan), del Karakorum (Broad Peak), delle Ande Argentine (Fitz Roy, Cerro Torre). Ha camminato e sciato in Islanda, Patagonia, Pakistan e India. Ha percorso gran parte dell’Italia in bicicletta, «un ottimo metodo per osservare lo sviluppo dell’economia per come è e non per come si dice che essa sia». In Italia il suo legame forte è con le montagne del Gruppo alpino Ortles - Cevedale che, partendo dalla sua baita in Valfurva, ha percorso metro per metro, in ogni stagione e con ogni mezzo, rigorosamente esclusi i mezzi a motore. Ma ha anche girato a lungo la Sicilia di cui è profondo conoscitore, partendo dalla sua casa nelle Isole Egadi, che frequenta da 40 anni.
Ha svolto compiti professionali di rilievo in vari campi dell'economia d’impresa, dove il leit-motiv caratterizzante è sempre stato l'innovazione, le nuove frontiere, la modernizzazione dell’economia italiana. Si è laureato in scienze delle Finanze a Pavia, dove è stato alunno del Collegio Ghislieri. Dirigente e giovanissimo socio dell’Arthur Andersen & Co., trascorre gli anni centrali della sua formazione, dal 1962 al 1979, nell’interno del mondo societario e professionale americano e internazionale. Si specializza nell’analisi dei bilanci, nei problemi della pianificazione aziendale e nelle tecniche di acquisizione di aziende. Svolge attività di consulenza per primari complessi aziendali internazionali ottenendo significativi riconoscimenti professionali e vasta esperienza mondiale. In questa veste è tra i pionieri e principali protagonisti dell’introduzione e sviluppo della certificazione dei bilanci in Italia.
Nel 1979 lascia l’Arthur Andersen e fonda una propria società di consulenza di alta direzione, la Vitale-Novello & Co. S.r.l., di cui è sempre stato presidente e principale animatore. Si dedica all’innovazione culturale e organizzativa dei gruppi imprenditoriali famigliari che aiuta a evolvere come importanti gruppi internazionali, senza stravolgerne l’originaria natura come consulente, consigliere d’amministrazione o presidente. Tra questi: Gruppo Same-Deutz, trattori; Gruppo Recordati, farmaceutici (quotata alla Borsa di Milano); Smeg, elettrodomestici; LU-VE, scambiatori di calore; Snaidero, cucine componibili; Ermenegildo Zegna, tessile e abbigliamento; Vincenzo Zucchi, biancheria della casa (quotata alla Borsa di Milano).
Da marzo 2010 a giugno 2013 presidente del Fondo Italiano d’Investimento nelle Piccole e Medie Imprese, nato dalla collaborazione tra Tesoro, Confindustria e sistema bancario, nomina ricevuta direttamente dal Ministero del Tesoro. Co-fondatore e primo presidente operativo, dal 1984 al 1992, delle società del Gruppo Arca, costituito da un importante gruppo di banche popolari, è pioniere in Italia dell’attività di gestione dei fondi di investimento e del merchant banking. Nel 1986 è nominato presidente dell’Associazione delle Merchant Bank italiane (AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital), che contribuisce a creare e che presiede per sedici anni. È stato vice-presidente e membro del Comitato Esecutivo della Banca Popolare di Milano (BPM) dal 2001 al 2009 ed è stato, sino al 2008, presidente di Bipiemme Gestioni SGR, società del risparmio gestito del Gruppo BPM, è consigliere della Banca Passadore. Generosa è sempre stata l’attività di docenza: ha condotto corsi molto innovativi sui valori imprenditoriali all’Università di Pavia, alla Bocconi di Milano, all’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) di Ancona e alla Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA). Di quest’ultima è stato il principale ideatore, co-fondatore, animatore e vice-presidente.
Negli ultimi anni si è molto impegnato nello sviluppo dei valori e dei metodi imprenditoriali nell’amministrazione degli Enti locali e nel Mezzogiorno, dove i suoi impegni più significativi sono stati quelli di presidente del nuovo terminal container al porto di Gioia Tauro (RC), dove «ho approfittato per camminare sulle affascinanti montagne calabresi», e di consigliere della Società per lo Sviluppo dell’Imprenditoria Giovanile. Nel marzo 1999 è stato nominato, dal Presidente del Consiglio, Commissario Unico per il coordinamento e l’utilizzo dei fondi privati per l’aiuto umanitario ai profughi del Kosovo (Missione Arcobaleno), esperienza che lo ha messo in contatto con il mondo degli operatori umanitari italiani e internazionali e gli ha permesso di istituire un fondo di microcredito con il prof. Yunus, fondatore di Grameen Bank e premio Nobel per la Pace, del quale è diventato amico.
Cattolico, liberale, studioso delle Encicliche sociali della Chiesa, si impegna anche sul fronte pubblico: presidente delle Ferrovie Nord di Milano; Assessore alle attività economiche del Comune di Milano; Commissario straordinario dell’Ospedale Maggiore-Policlinico di Milano; consulente di varie Province e Comuni nei processi di modernizzazione e privatizzazione e nello sviluppo dei loro piani territoriali e strategici. Anche in questo mondo tenta di introdurre valori e metodi professionali e manageriali, ricavandone un mare di frustrazioni, ma anche qualche significativa realizzazione. È membro del Movimento Federalista Europeo dal 1955, del Comitato Direttivo della Fondazione Olivetti e del Consiglio della Fondazione FAI (Fondo Ambiente Italiano). È vice-presidente del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo e presidente della Rino Snaidero Scientific Foundation. E’ stato presidente della Orchestra e Coro Sinfonico Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2014 è stato nominato membro del Consiglio di Brescia Musei su indicazione del Comune di Brescia.
Editorialista di importanti quotidiani e autore di numerosi scritti e libri, tra cui: La riforma delle Società per Azioni, Giuffrè, 1975; La lunga marcia verso il capitalismo democratico, Il Sole 24 Ore, 1989; Le Encicliche sociali, il rapporto tra Chiesa ed Economia, Il Sole 24 Ore, 1991; Liberare l’economia, le privatizzazioni come terapia alla crisi italiana, I grilli - Marsilio, 1993; Sviluppo e Spirito d’Impresa, Il Veltro Editrice, 2001; America, punto e a capo. Una lettura non conformista della crisi dei mercati mobiliari, Libri Scheiwiller, 2002; Fenomeno Chievo. Economia, costume, società. Una squadra di quartiere contro il calcio miliardario, Libri Scheiwiller, 2002; Il mito Alfa, Egea, 2004; Arturo Benedetti Michelangeli. La perfezione si fa musica, Castelli Bolis Poligrafiche, 2005; Lezioni di Impresa da tempi e luoghi diversi, Piccola Biblioteca di Impresa Inaz, 2008; I proverbi di Calatafimi. Antichi e modernissimi: punti di vista inusuali sui grandi temi dell’Impresa, Piccola Biblioteca di Impresa Inaz, 2008; Viaggio nell'economia campana, Ed. Giunta, 2008; Gli angeli nella città, Edizioni Studio Domenicano, 2008; E' in sostanza un problema di libertà - Vita e ideali di don Luigi Sturzo, Edizioni Studio Domenicano, 2009; Passaggio al futuro - Oltre la crisi attraverso la crisi, EGEA, 2010; Corruzione, Edizioni Studio Domenicano, 2010; Responsabilità nell'Impresa, Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2010; Longevità, Edizioni Studio Domenicano, 2011.
A CAUSA DELL’USO SCRITERIATO E SENZA AUTORIZZAZIONE
DELLE IMMAGINI DEL NOSTRO SITO
COMPIUTO DA ALCUNI SOGGETTI ANCHE SUI LORO PROFILI SOCIAL,
DAL 7 FEBBRAIO 2021 ABBIAMO DECISO DI RENDERE NON VISIBILI
LA MAGGIOR PARTE DELLE NOSTRE FOTOGRAFIE
CHE DAL 2014 AVEVAMO MESSO SUL SITO PER GLI ANNI DEL CENTENARIO.
NEL RICORDARE CHE L’USO DI IMMAGINI DI ASDM E’ VIETATO
E CHE CI RISERVIAMO OGNI AZIONE LEGALE VERSO I CONTRAVVENTORI,
PUR DISPIACIUTI DI PRIVARE MOLTI AMICI DI QUESTA OPPORTUNITA’
PER COLPA DI ALCUNE PERSONE INQUALIFICABILI E
VISTA ANCHE LA DERIVA ASSUNTA DAI “SOCIAL”,
PER LE NOSTRE COLLEZIONI FOTOGRAFICHE NON PIU’ QUI VISIBILI,
RESTIAMO A DISPOSIZIONE DEGLI STUDIOSI CHE POTRANNO CONTATTARCI
TRAMITE I CONSUETI CANALI E-MAIL